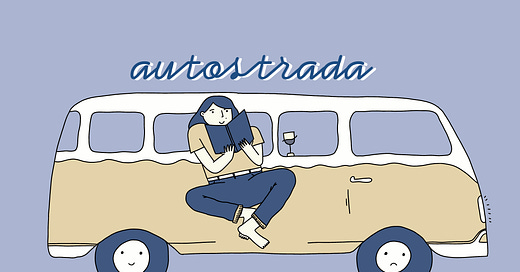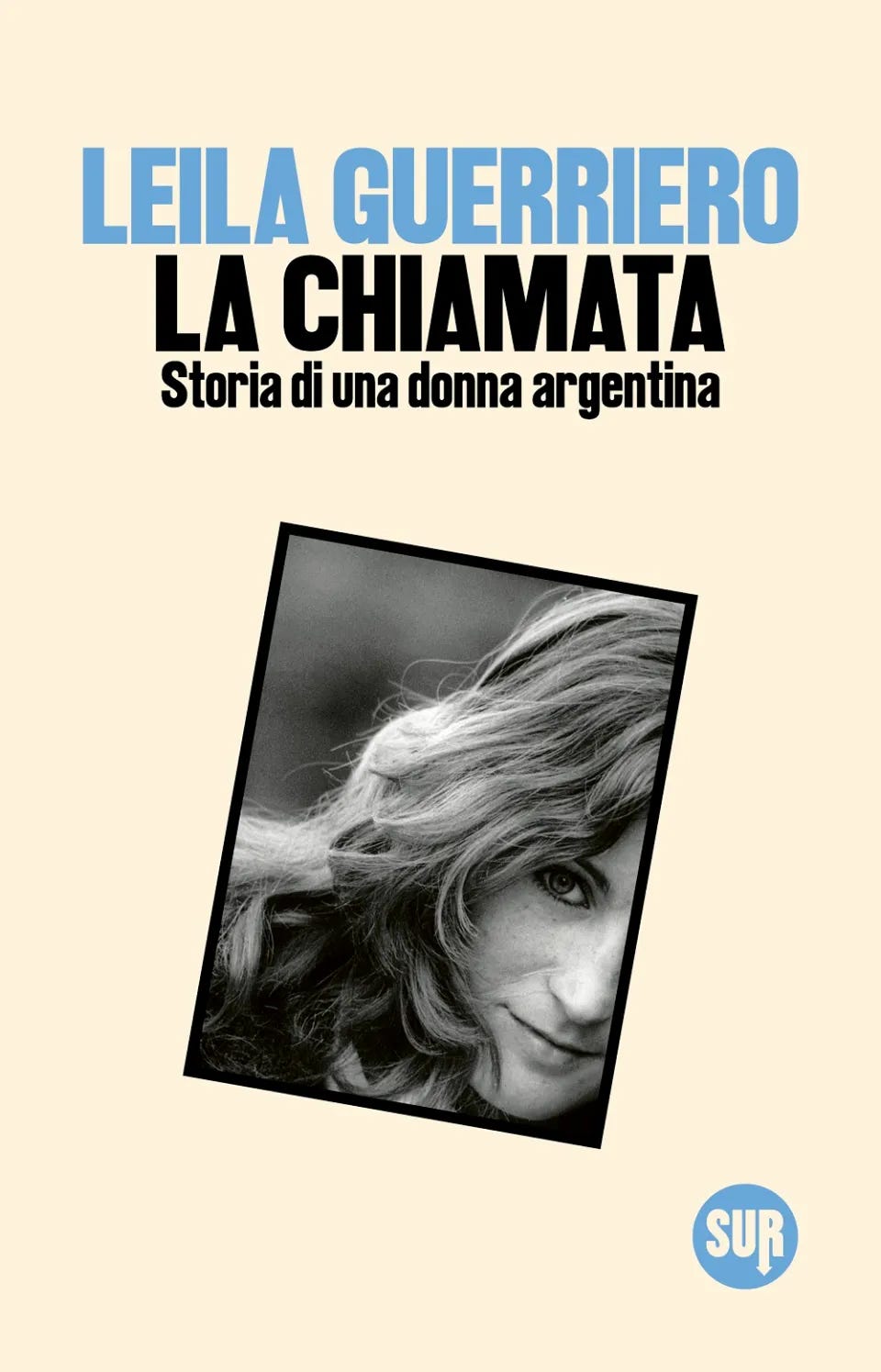Autostrada del sud #47 - Io profondo e io sociale
Nella prefazione di Scrivere la distanza. Forme autobiografiche nell’opera di Annie Ernaux, Ornella Tajani racconta il gesto di decentramento che Ernaux mette in atto parlando di sé nei suoi romanzi, “spostando il valore dell’io all’interno del lavoro personale”. Il testo, prima di affrontare i temi di “autosociobiografia”, “biografia linguistica” e di “scrivere la vita”, si sofferma brevemente sul pensiero di Pierre Bourdieu, filosofo e sociologo fondamentale nella formazione della scrittrice normanna. Riassumendo ai minimi termini, Bourdieu dice che l’io profondo è legato all’io sociale senza possibilità di scissione. L’individuo non è cioè impermeabile dalla società, e anzi, chi siamo è la naturale conseguenza della nostra posizione all’interno della società. Bourdieu sviluppa un nuovo concetto di habitus, secondo cui chi siamo è il frutto sì dei condizionamenti sociali, culturali ed economici con cui ci siamo confrontati, ma è anche qualcosa che a sua volta può plasmare il mondo fuori da noi, attraverso le nostre scelte e le nostre azioni. È cioè sia qualcosa di passivo che di attivo, perché se da un lato si crea a partire da condizioni esterne indipendenti dai soggetti, dall’altro può plasmare la realtà esterna attraverso l’azione1.
Questa non è una newsletter che parla di scienze sociali, ma ho pensato a Ernaux e ho pensato a Bourdieu leggendo La chiamata, il nuovo libro di Leila Guerriero, edito da Sur con la traduzione di Maria Nicola. E il fatto è di per sé strano, perché Leila Guerriero non è una romanziera, è una giornalista, e non parla mai di sé ma sempre di altro da sé.
La storia de La chiamata è quella di Silvia Labayru, ex militante dei Montoneros, un’organizzazione guerrigliera nata in Argentina alla fine degli anni ‘60. Durante i primi anni della dittatura di Videla, Silvia, figlia di una famiglia benestante di militari, intensificherà la sua attività di militante e verrà sequestrata nel 1976. Passerà il successivo anno e mezzo all’Esma, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, dove i militari rinchiudevano e sequestravano i prigionieri e gli oppositori politici. Silvia verrà torturata e violentata, partorirà la sua prima figlia, Vera, su un tavolo di quella ex scuola, vedrà sottrarle la figlia, che sarà riconsegnata alla sua famiglia, e vivrà col terrore di essere uccisa, una volta superato il parto. Poi succede qualcosa, ed è qui che i pezzi del puzzle prendono forme diverse. Grazie a un’imprevista chiamata, Silvia entrerà in quello che veniva definito “programma di riabilitazione”: di tanto in tanto potrà uscire, vedere il marito e la figlia, rientrando la sera nel suo stato di prigionia, continuando a subire una serie di violenze tremende che non sono più solo legate al terrore, ma a qualcosa di subdolo e sottile. Un anno e mezzo dopo, tornata in libertà per sempre, si dovrà scontrare con il giudizio dei suoi ex compagni di battaglia e di vita: perché 30.000 persone sono scomparse, perché migliaia sono state uccise, e lei è viva? Cosa ha fatto per essere graziata? Chi ha tradito?
La chiamata è una storia di non-fiction raccontata con rara maestria, in cui Guerriero ricostruisce la vita e la vicenda di Silvia non solo attraverso le sue testimonianze, ma anche intervistando e parlando con la sua famiglia, i suoi ex fidanzati, il marito, le persone che hanno dubitato di lei. Mentre si delinea la sua vita, si delinea anche la pagina della storia argentina con cui il Paese non riuscirà mai a fare i conti, quella dittatoriale e post-dittatoriale, in cui 40.000 persone sono state uccise o fatte scomparire. Io profondo e io sociale si specchiano continuamente uno nell’altro, non solo quando si parla di Silvia e del valore simbolico che può incarnare all’interno della Storia, ma anche nel mondo in cui Guerriero racconta questa vicenda. Chi siamo è il frutto del contesto in cui viviamo, e contemporaneamente quel contesto lo cambia, attraverso il nostro agire.
Si può sopravvivere all’inferno? E cosa succede se quando torni alla vita, scopri di doverne affrontare uno nuovo?
Leggete ogni cosa di Leila Guerriero, e nel farlo, partite da questo libro incredibile.
Libri letti in questi mesi.
L’anniversario di Andrea Bajani, Donnaregina di Teresa Ciabatti (che bello), Chiudo la porta e urlo di Paolo Nori (sì, ho iniziato a leggere italiani contemporanei), La vita agra di Bianciardi (capolavoro), Ultime interviste di Joan Didion (<3), In California con Joan Didion di Benedetta Faedi, Stelle cadenti di Laura Marzi e La chiamata di Leila Guerriero, come avrete avuto modo di intuire.
Mentre scrivo questa newsletter sto leggendo L’ultima acqua di Chiara Barzini e sto rileggendo Verso Betlemme di Joan Didion.
Libri in uscita o da recuperare
Sara Torres, Tutto quello che c’è, Fandango. Traduzione di Roberta Arrigoni.
“‘Mentre mamma moriva io facevo l’amore’, racconta la narratrice, una giovane accademica spagnola, da una stanza di hotel a Barcellona. Ha un volo per far visita a sua madre la mattina successiva, ma arriverà troppo tardi.
Poco dopo, la sua amante si allontana improvvisamente e definitivamente.
Quando la sua compagna arriva da Londra per trasferirsi da lei in un piccolo appartamento in riva al mare, la narratrice tenta di sostenere l’angoscia di un corpo sottoposto a una doppia assenza, che piange una madre e desidera un’amante. Come stare al mondo quando tutti i punti di riferimento sono scomparsi? ‘Amare è sempre amare dopo mia madre. Non posso parlare con mia madre, né con Lei. La mia vita si è fermata con l’interruzione di queste due conversazioni.’ L’autrice prova a comprendere una madre che le ha segnato la vita con il suo travolgente modo di essere e sonda i confini del dolore, dell’amore e del desiderio tra donne, madri e figlie. Attingendo alla letteratura, Sara Torres, pluripremiata poeta, debutta con un romanzo sensibile e sincero, a metà strada tra Deborah Levy e Jeanette Winterson. Un viaggio che conduce chi legge al di là delle paure, norme sociali e sensi di colpa, per godere della vita e dei suoi piaceri senza angoscia e perdonarsi.”
Alcide Pierantozzi, Lo sbilico, Einaudi editore.
Alcide ha quarant’anni, a volte dorme ancora con sua madre, prende sette pasticche al giorno (cinque la mattina e due dopo cena), ed è considerato «un paziente lucido, vigile, collaborativo, dall’eloquio fluido». È un essere umano «difettoso» tra i tanti, ma i suoi difetti stanno tutti dentro quattro pagine di diagnosi controfirmate da uno dei piú famosi psichiatri italiani: «disturbo bipolare», «spettro dell’autismo», «dissociazione dell’io», «antipsicotici», «pensieri di mancata autoconservazione»… Dal suo esilio in una cittadina dell’Abruzzo, dove ogni cosa sembra da sempre uguale a sé stessa, Alcide ci racconta il tempo melmoso delle sue giornate. Le ore in spiaggia, o a sfinirsi in palestra, dove va per riguadagnare in muscoli quello che ha perso in lucidità mentale. Soprattutto ci racconta – con tutta la chimica che ha in testa – cosa accade quando l’equilibrio psichico s’incrina: l’innesco della paranoia, la percezione che si sdoppia, il modo in cui il tempo fermo di un’attesa non è mai davvero fermo, perché è lí che arrivano i pensieri. Nel suo resoconto si alternano momenti di un prima a Milano, la città che da sola sembrava poterlo tenere in vita, e di un prima ancora, un’infanzia in cui tutto faceva già troppo male ma a salvarlo c’erano la nonna, la bicicletta, tutto uno zoo di animaletti di campagna. Nel presente, invece, c’è la vita con sua madre, che è insieme origine, scandaglio e unico argine possibile delle sue psicosi. E poi c’è l’ossessione per le parole: la ricerca quotidiana in biblioteca, nei dizionari, nei libri, dei termini esatti, che sappiano ridurre l’irriducibile, nominare l’innominabile. Questa è la storia di uno sperdimento, una storia che possiede il dono e la condanna di saper parlare davvero a chiunque. A chiunque, almeno una volta, non si sia riconosciuto nel proprio riflesso allo specchio; a chiunque abbia sentito la realtà passargli accanto come un vento laterale; a chiunque abbia messo in dubbio la fondatezza dei propri pensieri e dei propri desideri. Sono pagine brucianti, che Alcide Pierantozzi ha scritto come se il suo corpo fosse un sismografo, registrando il disagio psichico nella sua forma piú pura, descrivendo la violenza – poetica e brutale – di una mente smarrita che cerca di trovare una stabilità impossibile, ma che sempre, sempre, prova a salvarsi. Lo sbilico dà voce a un bisogno collettivo fortissimo: quello di nominare con precisione il malessere psicologico, l’alienazione, la medicalizzazione e la solitudine. Un’impresa che può fare soltanto la grande letteratura. «Noi matti non abbiamo solo il diritto di essere soccorsi dai sani, ma anche il dovere di inceppare ogni giorno il mondo per metterlo in discussione ai loro occhi».
Alejandra Costamagna, Impossibile lasciare la terra, Edicola. Traduzione di Maria Nicola.
“Impossibile lasciare la Terra è un quartiere che si incastra perfettamente nella città letteraria costruita da Alejandra Costamagna, pluripremiata scrittrice cilena di cui Edicola ha già pubblicato il romanzo Il sistema del tatto e la raccolta di racconti C’era una volta un passero. Un quartiere abitato da gente sola, gente ossessionata, gente che si suicida però prima mangia e trova che il purè dell’ospedale sia delizioso. Costamagna è un orecchio che cammina per le strade, una predatrice di frasi, una fanatica della minuzia. Le sue storie divampano senza il minimo stridore, l’amabile sobrietà della sua scrittura pulsa sotto ogni assurda vicenda, e i suoi personaggi - così commoventi nel loro delirio di contraddizioni - sono calamite che trattengono chi legge in una realtà impossibile da lasciare.”
William Atkins, Tre isole, Iperborea. Traduzione di Luca Fusari.
“Era il 2016 e William Atkins veniva scosso da due immagini gemelle, distanti migliaia di chilometri: i cumuli di salvagenti lasciati dai rifugiati sulle spiagge greche, visti in televisione, e gli ammassi di zaini abbandonati dai migranti sudamericani nel deserto dell’Arizona, visti di persona. Da qui nasce il viaggio di Tre isole: l’esigenza di trovare un altrove in cui stare meglio, che è alla base di tutte le migrazioni della storia, sembra ancora oggi animare il mondo. Ma cosa succede quando la migrazione è forzata, quando un Impero ha la facoltà di rimuovere personaggi scomodi e confinarli oltremare? Atkins racconta la nostalgia di tre esuli, tre ribelli sconfitti dalla storia del XIX secolo: Louise Michel, amica di Hugo, anarchica a capo della Comune di Parigi; Dinuzulu, figlio dell’ultimo re zulu riconosciuto dai coloni britannici; l’ebreo ucraino Lev Šternberg, dissidente antizarista, padre dell’etnografia russa. Atkins li segue nella terra del confino: in Nuova Caledonia, isola divisa tra identità tribale e dipendenza dalla Francia. Poi a Sant’Elena, esilio di Dinuzulu, scoglio disperso nell’Atlantico che oggi sembra un «ospizio a tema impero» in cui andare a caccia di farfalle e riscoprire un passato di schiavitù. Infine, come Šternberg, viaggia in nave nell’Estremo Oriente russo fino a Sachalin, arricchita oggi dal petrolio, ma come un tempo brutale e inospitale, soprattutto con gli indigeni nivchi. Un viaggio tra presente e passato per capire lo sradicamento di tre condannati alla nostalgia e la verità che sta al centro dell’esperienza dell’esilio e delle sue contraddizioni – libertà e prigionia, lontananza e vicinanza, imperialismo e ribellione.”
Maggie Nelson, Pathemata, O, la storia della mia bocca, Nottetempo. Traduzione di Alessandra Castellazzi.
“Secondo pannello di un dittico avviato nel 2009 con Bluets (pubblicato in Italia da nottetempo nel 2023), Pathemata, O, la storia della mia bocca tocca con grazia le corde più intime dell’esperienza umana, fondendo insieme il “diario di una paziente” – ovvero il racconto di un decennio di dolore alla mascella – e l’esplorazione personale del punto di unione tra onirico e ordinario. Nelle parole di Maggie Nelson l’inconscio si insinua nella quotidianità e svela timori taciuti, ferite represse. Passando dalle proprie vicissitudini cliniche al territorio inesplorato della maternità, dagli inciampi di un rapporto amoroso agli squarci lasciati dal lutto, l’autrice si mette a nudo con una scrittura evocativa, musicale ed essenziale. Nelson ci fa sentire con forza inedita l’emozione più profonda e vera: tutti noi abitiamo un corpo capace di provare amore e dolore, patimenti e passioni, tutti noi siamo presi dallo sforzo costante di connetterci con gli altri.”
Varie ed eventuali
Torna All you need is Pop, la festa di Radio Popolare. Tre giorni di eventi, spettacoli, presentazioni al Parco dell’Ex Paolo Pini. 6, 7 e 8 giugno. La libreria presente a tutti gli eventi, a volte col dono dell’ubiquità, sarà la Libreria Alaska, la libreria indipendente di Affori di cui sono socia. Venite?
A un certo punto, qualche settimana fa, il 50% delle persone di cui guardo le storie postava questo pezzo. In effetti è molto bello.
Chi l’avrebbe mai detto, “Nei primi tre mesi del 2025 in Italia sono stati venduti 810mila libri in meno rispetto all’anno scorso”.
La resa di Milano al cemento, un articolo di Sarah Gainsforth su Internazionale.
Un’intervista a Ocean Vuong. Bentornato Ocean Vuong.
I lavoratori della cultura sono sfruttati e divisi. Perché non riescono a unirsi? Un pezzo di Loredana Lipperini su Lucy.
Sempre su Lucy, Giorgia Sallusti intervista Mathias Enard.
Il nuovo podcast di Sara Poma per Raiplay: La città d’amianto.
La serie tv L’eternauta, adattamento del fumetto di Oesterheld, disegnato da Solano Lopez, è sbarcato su Netflix. Un approfondimento sul sito argentino Revista Anfibia.
Torna La Grande Invasione, il festival più bello che c’è.
Una parola
Malmostoso - mal-mo-stó-so | Scontroso, contrariato.
Dal lombardo malmostós, composto di mal e mostós ‘sugoso’.
Un link
Un podcast che è anche un account instagram che è anche una newsletter.
Tutte e tre parlano di Stephen King. Tutte e tre sono opera di Jacopo Cirillo e Giulio D’antona.
Un album
Questa puntata è stata scritta ascoltando Schegge di Giorgio Poi.
Vi saluto perché è iniziato il Roland Garros e devo andare a perdere la voce davanti al proiettore.
Ci si risente tra un paio di mesi, nel frattempo leggete irresponsabilmente e occhio ai colpi d’aria (disse quella con l’influenza da giorni).
Come sempre, se volete dirmi qualcosa potete rispondere a questa mail, oppure mi trovate su Instagram (X lo abbiamo abbandonato per ovvie ragioni e ancora non mi sono appassionata ai suoi sostituti).
Ciao!
Silvia
L’autostrada disegnata è di Elisa Lipari.
Gabriella Paolucci, Introduzione a Bourdieu, Laterza, 2011